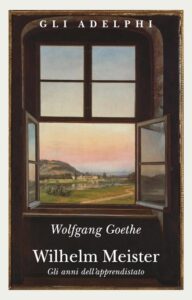Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister [di Roberto Gilodi]
|
https://www.doppiozero.com 27 Settembre 2023. Goethe è stato, a detta di tutti i suoi contemporanei, una figura impossibile da inquadrare negli schemi antropologici, morali, culturali e poetici che hanno caratterizzato gli ultimi tre decenni del XVIII secolo e i primi due di quello successivo. L’età che in Germania chiamano, forse per un eccesso di devozione ex post, la Goethezeit ma che a Goethe, a ben vedere, non sembra assomigliare molto. Di fronte alla sua figura può apparire strana l’impotenza della critica coeva, ma in parte anche di quella successiva, che pure si è spesa su di lui senza risparmio di energie, tanto che non si contano i volumi sulla sua opera e la sua figura umana. Una stranezza che appare ancora più inspiegabile se si considera che la vita di Goethe è stata caratterizzata da una quasi ininterrotta confessione pubblica sia nella veste di critico militante sia in quella di saggista, o ancora nella forma epistolare e nelle interpolazioni saggistiche che abbondano nelle sue opere. In altre parole, Goethe non si è mai sottratto alla necessità di dire cosa pensasse della letteratura del suo tempo e di quelli che sono stati i grandi modelli dell’autocoscienza letteraria occidentale: gli antichi, la classicità e le diverse letture che di essa sono state date nel corso dei secoli. Non meno della sua figura intellettuale e artistica appare ambiguo e incollocabile il suo secondo capolavoro narrativo, Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister (Trad. It. Emilio Castellani, Adelphi, 2006), che seguiva a distanza di vent’anni il suo fortunato I dolori del giovane Werther, che lo rese celebre in tutta Europa. Già i giovani intellettuali della prima stagione romantica avevano percepito che il romanzo aveva una sua peculiare cifratura che gli conferiva un sapore vagamente esoterico e che le peripezie del giovane eroe erano segnate da un’aura di mistero che rendeva difficile capirne il senso. E misteriose erano alcune delle figure che l’eroe protagonista incontra nei suoi viaggi attraverso la Germania al seguito di una compagnia di teatranti girovaghi. In particolare Mignon, che si rivela un grumo simbolico talmente complesso che dipanarne la tessitura si è dimostrata un’impresa inesauribile. Fin dal suo primo apparire la fanciulla adolescente, acrobata, dai tratti vagamente efebici, sconvolge Wilhelm: “Come ti chiami? Egli chiese. «Mi chiamo Mignon». «Quanti anni hai?». «Nessuno li ha mai contati». «Chi era tuo padre?». «Il gran diavolo è morto» (…) La ragazzina rispondeva in un tedesco stentato e con una singolare solennità, ogni volta portandosi le mani al petto e alla fronte e facendo una riverenza. Wilhelm non si saziava di guardarla, gli occhi e il cuore irresistibilmente attratti dall’alone di mistero che circondava quella creatura. Dimostrava dodici o tredici anni; il suo corpo era ben proporzionato, ma le sue membra promettevano uno sviluppo maggiore, o ne denunciavano uno ritardato. I suoi tratti non erano regolari ma colpivano: la fronte piena di mistero, il naso straordinariamente bello, e la bocca, sebbene la tenesse troppo serrata per la sua età e ogni tanto contraesse lateralmente le labbra, serbava però ancora molta ingenuità e fascino. La carnagione bruna era riconoscibile a fatica sotto il trucco. Wilhelm si sentiva profondamente impressionato da quella figura; seguitava a guardarla in silenzio e la sua contemplazione gli faceva dimenticare i presenti.” Mignon è il contraltare simbolico, cifrato e misterioso della solare esperienza del mondo di Wilhelm. Se quest’ultimo procede per tentativi ed errori e incarna quella curiositas fatta di desiderio ed eticità che si esprime nell’intraducibile verbo tedesco ‘streben’, ossia nella tensione indomabile verso una meta imprecisata, Mignon segnala che esiste una dimensione del mistero che la razionalità discorsiva non può penetrare. Chi, come Wilhelm, vuole darsi una ragione dell’accadere, è costretto di continuo a fare i conti con le forze telluriche che si agitano sotto la superficie del mondo. È come se nel romanzo ci fosse una doppia anima: un lato in luce, che accompagna le svolte della vita del protagonista e uno in ombra, che mina i progetti di senso che l’eroe abbozza, per poi sconfessarli e costruirne di nuovi. E così la narrazione scorre in due alvei paralleli e distinti, uno visibile e l’altro carsico, uno spiegabile con le strumentazioni logiche che le poetiche da Aristotele in avanti hanno richiesto ai poeti e uno indecidibile sul piano causale, dove si cerca invano una ratio che ne spieghi gli sviluppi. In quest’ultimo si raccolgono le aporie, le dissociazioni tra il volere e l’agire, tra il contingente e il remoto, tra il qui ed ora e lo struggimento nostalgico per un altrove che si fa cifra dello spirito e che platonicamente aspira a congiungersi con un’origine irraggiungibile. Questa filigrana ‘erotica’ sublimata governa gli strati profondi del romanzo e li colloca su un piano metafisico al cospetto del quale la progressione esistenziale e di formazione di Wilhelm in fondo è poca cosa. Bildung è la parola chiave che ha governato nella Germania tra Sette e Ottocento il desiderio di cambiamento di un mondo fossilizzato nei rigidi ruoli della società di status. Cambiamento morale, spirituale, culturale in cui si riconosce un’umanità nuova, fiduciosa di potersi emancipare dalla soggezione secolare a chi ha governato il corpo e la mente dei propri sudditi. E il Bildungsroman ha trasformato radicalmente il senso dell’avventura: non più le peripezie eroiche di re, principi e cavalieri ma l’ordinary life di un giovane che fa esperienza del mondo. Questo percorso di emancipazione e insieme di sperimentazione di se stessi è l’essenza del romanzo di formazione. In esso convergono i saperi dell’antropologia, della psicologia sperimentale e della filosofia morale dell’Illuminismo. Il suo telos è la Vollkommenheit, la maturazione armonica dell’individuo. Ebbene, Goethe era convinto che gli sforzi della ragione di imbrigliare la complessità del mondo nella costruzione ordinata di un sistema di concetti fosse sì una mirabile cosa di cui è capace l’uomo, ma che, per un’ironia della sorte, quello sforzo fosse destinato a non cogliere l’essenza delle cose. Le grandi costruzioni di senso, per esempio la minuziosa e formidabile classificazione scientifica degli organismi viventi proposta da Linneo, offre l’opportunità di mappare l’infinita varietà della natura, di inquadrarla in un ordine rigoroso che appaga la mente, ma finisce per rivelarsi una geniale finzione a cui sfugge un aspetto essenziale: l’instabilità perenne dei dati naturali, la loro continua metamorfosi. A partire dagli anni novanta del Settecento per Goethe la vera sfida non sarà la sistemazione dell’esistente, ma capire il perenne mutare degli enti naturali prendendo atto dell’impossibilità di determinare un qui ed ora, perché lo scorrere del tempo tiene perennemente in scacco gli sforzi planimetrici della ragione. Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister possono quindi essere visti come una sorta di rappresentazione teatrale volta a mettere in scena l’eterno conflitto tra la hybris progettuale di chi è certo di come si governa una vita in modo razionale e l’insidia perenne della dynamis, del moto inarrestabile delle cose e degli esseri umani che cambia continuamente le carte in tavola. Se Giulio Camillo ha dato vita all’utopia umanistica di un teatro della memoria, Goethe col Meister allestisce un teatro dei progetti di senso intorno al grande tema della realizzazione compiuta della vita. La Vollkommenheit si rivela una chimera a cui fa da controcanto una morfologia dell’incompiuto, ossia la soglia problematica tra adolescenza e prima giovinezza. È curioso come entrambi questi progetti teatrali a prima vista appaiano animati dalle stesse intenzioni: creare un sistema delle equivalenze, una grandiosa topica simbolica. Eppure, a osservarli da vicino appaiono profondamente diversi, per non dire opposti: la macchina teatrale di Giulio Camillo è governata dall’ottimismo della ragione, la costruzione simbolica goethiana è attraversata dal disincanto. Quando Friedrich Schlegel leggerà il romanzo di Goethe sarà preso da una sorta di vertigine per l’architettura bizzarra dell’insieme e per le figure che popolano il palcoscenico del romanzo. La critica contemporanea lo aveva accolto con estrema freddezza: lo stesso Schiller, in quegli anni sodale stretto del poeta di Weimar, manifesterà la sua perplessità all’amico per un esito che disattendeva tanto l’ideale di una educazione estetica dell’umanità quanto le più elementari regole compositive della poetica aristotelica. Dov’erano la poesia, l’unità d’azione, l’epilogo all’altezza delle premesse? In luogo di questi requisiti fondamentali il romanzo presentava secondo Schiller “una strana oscillazione tra intonazione prosaica e poetica a cui non so dare un nome”. E di questo in effetti si tratta, di una indecifrabile intonazione in cui la mera successione dei fatti si intreccia alla misteriosa rete di riferimenti simbolici che finiscono per disarticolare la costruzione narrativa. Dinanzi all’impasse schilleriano e della critica coeva Friedrich Schlegel si produrrà in una completa ed entusiastica celebrazione del Meister. Cosa affascinava Schlegel? Esattamente ciò che impensieriva Schiller: la mancanza di un plot coeso e di un telos esplicito. Schlegel, al contrario, legge il romanzo con un’aspettativa completamente differente: vede nella successione dei quadri narrativi, nel loro apparente disordine, un ordine nascosto, sotteso alla trama, una rete di rimandi e di connessioni che costituisce per così dire un secondo romanzo, quello vero, il suo contenuto di verità, come avrebbe detto poi Walter Benjamin a proposito delle Affinità elettive. Lo schema che i romantici videro all’opera nel Meister non era diverso da quello che essi avevano individuato nella costruzione dei dialoghi platonici: un’esposizione esoterica che nascondeva una verità sistematica. E questo fondamento aporetico Friedrich Schlegel lo espresse con una metafora musicale definendo il romanzo “un’armonia di dissonanze”. In altre parole, i romantici di Jena videro nel romanzo goethiano la prima concretizzazione della loro poetica, vale a dire l’espressione più compiuta del ‘romanzo romantico’, la nuova frontiera della poesia, quella che finalmente era adatta ad esprimere le aporie di cui è intessuto il mostro epocale che si andava delineando e che si chiamerà da lì in avanti “Modernità”. Di questa discontinuità epocale il romanzo rifletteva le movenze, la forma, la disarmonia. La sua costruzione narrativa rifletteva le asimmetrie di una età votata al cambiamento e alla perdita delle certezze politiche, sociali e metafisiche che avevano governato il corso dei secoli precedenti. La lettura schlegeliana del Meister vedeva nel romanzo non solo il riflesso formale di una età della transizione, ma anche l’occasione per ripensare il modo in cui interpretare un’opera letteraria. “È bello e necessario abbandonarsi completamente all’impressione di una poesia, lasciare che l’artista faccia di noi ciò che vuole, e piuttosto corroborare, solo in qualche dettaglio, per mezzo della riflessione, ciò che si prova ad elevarlo a pensiero; (…) Ma non è meno necessario saper astrarre dai singoli aspetti, cogliere al volo l’insieme, estendere lo sguardo a una quantità cospicua di elementi e afferrare l’intero, per poter addirittura indagare ciò che vi è di più nascosto e collegare le parti più lontane.” Questa lezione di metodo ermeneutico farà scuola. Leggere un’opera è provare il piacere che generano le parole e la storia di cui parlano, ma è nello stesso tempo scoperta della sua natura profonda, della verità che in essa si cela e che se è davvero tale, secondo i dettami della tradizione ermetica, non potrà mai manifestarsi. In conclusione, che tipo di opera è dunque il Meister? Un’opera mondo? Non lo è perché la vicenda narrata, come avevano avvertito già i contemporanei, di esemplare ha ben poco, di eroico proprio nulla. Eppure, a modo suo, lo è perché pochi romanzi hanno saputo come il Meister di Goethe rappresentare con calviniana leggerezza la natura indecidibile, polimorfa e aporetica della Modernità.
|