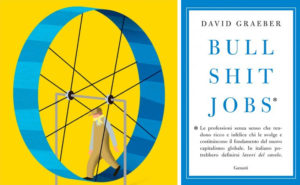L’economia dei lavori fasulli [di Nicolò Bellanca]
|
MicroMega.com 27 novembre 2018. Immagina un ufficio nel quale ogni funzionario, aspirando al prestigio e al potere, vuole moltiplicare i suoi subordinati e ridurre i suoi rivali. Per ottenere questo scopo, il burocrate A si lamenta con i suoi superiori (che sia vero o meno!) di avere troppo lavoro da svolgere. Esistono tre fondamentali risposte alle sue lagnanze: può dividere il lavoro con un collega di pari livello B, oppure può farsi aiutare da un subordinato C, o infine può ottenere l’assunzione di due subalterni, C e D. La soluzione che si avvale di B non gli sta bene, poiché costui sarebbe un rivale per la promozione. Nemmeno gli aggrada la soluzione in cui viene assunto soltanto C, in quanto costui costituirebbe il suo unico sostituto, e quindi un suo potenziale rivale. Se invece entrano in ufficio C e D, il funzionario A li comanda facilmente, mettendo l’uno contro l’altro, e accresce il proprio prestigio e potere, essendone il capo. Dopo un po’ di tempo, l’impiegato C si lamenterà (che sia vero o meno!) di avere troppo lavoro; in base alla stessa logica, arriveranno E ed F. Si lagnerà anche D e giungeranno G e H ad aiutarlo. Così otto burocrati copriranno i compiti che all’inizio svolgeva uno solo! Ho appena ricordato la cosiddetta “legge di Parkinson”, secondo cui le organizzazioni tendono a espandersi indipendentemente dalla quantità di lavoro da svolgere[1]. In due suoi libri recenti, l’antropologo David Graeber si sofferma sullo stesso fenomeno: la burocratizzazione del mondo e il proliferare di lavori superflui, privi di senso e perfino dannosi[2]. Graeber distingue i “lavori socialmente utili” mediante un esperimento di pensiero: chi di noi sentirebbe la mancanza di una determinata mansione, se essa scomparisse dall’oggi al domani? Assolutamente vitali per la società sono attività monotone, usuranti e senza prestigio, come l’infermiere, il netturbino, il meccanico, il conducente di autobus, il commesso del negozio di alimentari, il vigile del fuoco, il contadino o il cuoco. Plausibilmente rilevanti sono il maestro di scuola elementare o certe categorie di scrittori, artisti e musicisti (senza i quali il mondo sarebbe un luogo più triste); ma anche chi fabbrica beni tangibili di consumo quotidiano, chi eroga servizi qualificati nell’ambito della salute pubblica (come il medico) o chi, esercitando per “volontariato” mansioni altruistiche, spesso nemmeno viene retribuito. Piuttosto – specialmente in ambito burocratico e finanziario, così del settore pubblico come di quello privato –, un buon numero di colletti bianchi vengono pagati per non fare nulla l’intera giornata. In termini di efficienza economica, si tratta di lavori fittizi, fasulli, sostanzialmente inventati, che appesantiscono i costi dell’organizzazione e che quindi costituiscono attività irrazionali. Il loro scopo principale è extraeconomico: tenere impiegata una fascia della popolazione che altrimenti – di fronte alla debolezza della crescita mercantile e al dilagare dell’automazione – rimarrebbe disoccupata. Questa economia fasulla (bullshitisation) si articola per Graeber in cinque principali comparti. La funzione dei “tirapiedi” consiste nel far sentire importanti i superiori con servigi spesso inutili. Gli “sgherri” hanno il compito di convincerci che la loro organizzazione è migliore delle altre; spesso addirittura sono reclutati per consentire all’organizzazione di affermare che sta facendo qualcosa che in effetti non sta facendo, come accade per quelli che ne curano l’immagine su tematiche socialmente ed eticamente sensibili. I “ricucitori” risolvono problemi che non dovrebbero esistere, essendo generati da gaffe, errori e pigrizie dei propri capi. I “barracaselle” (o “passacarte”) sono addetti a compilare moduli e rapporti che nessuno guarderà. I “capomastri”, infine, sono controllori il cui lavoro si riduce a guardare altri che lavorano, nonché a inventare compiti inutili per tenere occupati i sottoposti. Graeber dedica molte pagine a illustrare che chi svolge lavori fasulli o “del cavolo” (bullshit jobs) ne è consapevole. Semplicemente, deve evitare di riconoscerlo. Privatamente può lamentarsi, percependo la propria vita come priva di senso. In ufficio può trascorrere ore e ore in attività completamente estranee al mansionario per il quale riceve lo stipendio. Ma formalmente deve manifestare apprezzamento per l’organizzazione che lo recluta, difendendola nei riguardi dei suoi critici. La sua è dunque una condizione esistenziale schizofrenica, nella quale una parte della propria identità annaspa, fatica a rassegnarsi e talvolta prova a scappare, mentre l’altra parte è intrappolata in un copione prestabilito da recitare invariabilmente giorno dopo giorno. Né basta sottostare al ricatto del licenziamento, alla lealtà verso il superiore e all’accettazione passiva delle procedure. La fedeltà all’organizzazione richiede la complicità: «gli scatti di carriera […] dipendono soprattutto da quanto si è disposti a stare al gioco, facendo finta che si basino sul merito»[3]. L’economia fasulla spinge alle estreme conseguenze il processo di burocratizzazione. Se inizialmente si introducono mansioni burocratiche per risolvere un problema, l’organizzazione, una volta che incorpora quelle mansioni, incontra nuovi problemi i quali, a loro volta, appaiono affrontabili soltanto per via burocratica. In una battuta, si creano commissioni per risolvere il problema delle troppe commissioni[4]. Come nella “legge di Parkinson”, illustrata in apertura, anche ammettendo che il reclutamento del primo funzionario abbia un’utilità, i sette addetti che vengono successivamente impiegati danno forma ad uno stuolo di attività fittizie. La migliore comprova si incontra nelle organizzazioni che, essendo prive di progresso tecnologico, non avrebbero ragioni per modificare il proprio assetto. È il caso del mondo universitario. Da trent’anni, annota Graeber, negli Atenei statunitensi o britannici il numero di amministrativi supera quello dei docenti, e i docenti sono costretti a dedicare alle attività amministrative almeno lo stesso tempo che destinano a ricerca e insegnamento messi assieme. L’esito paradossale è un mare di scartoffie in cui si parla d’incoraggiare la creatività, ma che in effetti esiste proprio per strangolare qualsiasi creatività (e qualunque pensiero critico)[5]. Marx sosteneva che, per far funzionare il capitalismo, deve esistere un “esercito industriale di riserva”, formato di disoccupati. Adesso quell’esercito viene suddiviso in tre parti: accanto ai disoccupati veri e propri, vi sono i lavoratori fittizi che, essendo remunerati a vuoto, temono di perdere il loro privilegio e si mantengono abbarbicati allo status quo; e vi sono quelli che, immersi nell’incertezza e nel precariato, sono unicamente preoccupati di galleggiare. Così, applicando la logica del divide et impera, il sistema economico aumenta la propria capacità egemonica opponendo chi cerca lavoro, a chi ha un lavoro fittizio, a chi si batte nella gig economy. Graeber respinge la tesi, molto diffusa, per la quale questa evoluzione strutturale dipenderebbe dall’ascesa del settore dei servizi. La riconduce alla crescita della finanza, ma, più a fondo, allo svuotamento del modo capitalistico di produzione, a favore di un “feudalesimo manageriale” in cui ricchezza e potere sono attribuiti su basi non economiche, bensì politiche. Come il feudalesimo medioevale aveva la tendenza a creare infinite gerarchie di signori, vassalli e servi, così l’attuale sistema – basato sullo sfruttamento delle rendite di posizione – tende ad articolarsi in una infinita stratificazione nella quale quasi tutti siamo, allo stesso tempo, subordinati a qualcuno e superiori ad altri. La riflessione di Graeber – della quale abbiamo fin qui dato conto – ha il pregio di attirare l’attenzione su una delle principali strategie di consenso politico che oggi viene perseguita: l’economia dei lavori fasulli è un formidabile ammortizzatore sociale, nei riguardi di una crescita economica che non genera occupazione adeguata in quantità e in qualità[6]. Essa mostra però anche notevoli debolezze sul versante dell’indagine e della spiegazione teorica. Il volume Bullshit jobs non poggia su una documentazione empirica rigorosa e sistematica. Esordisce menzionando un sondaggio per il quale, in Gran Bretagna, quasi 4 intervistati su 10 (il 37%) giudica il proprio mestiere completamente inutile[7]. Ma, soprattutto, sostituisce la ricerca etnografica di campo, che nella tradizione antropologica richiede canoni metodologici severi, con pagine e pagine di brani tratti dalla “grande discussione online” che è seguita all’articolo iniziale di Graeber sull’argomento, rimpiazzando la “osservazione partecipante” con l’aneddotica. Passando al versante teorico, Graeber non può evitare la domanda centrale: come distinguere i “veri” lavori che creano valore da quelli fasulli? Qualunque risposta non può non discendere da una concettualizzazione dell’economia, implicita o esplicita che essa sia. Graeber prova a rispondere riferendosi all’autovalutazione delle persone: se un impiegato giudica privo di significato il proprio lavoro, esso è un “lavoro del cavolo”. Si tratta di un criterio imperniato su opinioni e credenze individuali, che non scontatamente collima con un altro, pure invocato da Graeber: che un determinato lavoro sia riconosciuto come benefico per altri sulla base di una valutazione collettiva. Anzi, ed è un punto cruciale per un pensatore anarchico (come Graeber si qualifica), tra i due criteri può aprirsi una divaricazione, ogni volta che la libertà dei singoli esprime preferenze e valori contrastanti le ideologie correnti. Consapevole della difficoltà, Graeber passa, verso la fine del suo libro, ad un terzo criterio: un’attività lavorativa è utile, e quindi dotata di senso, non quando genera beni tangibili o ricchezza materiale, né quando aumenta il tempo libero, e nemmeno quando accumula profitto per i capitalisti, bensì quando crea socialità. I lavori produttivi di valore sono insomma quelli che non vorremmo fossero svolti da una macchina, ossia i lavori di cura[8]. Con questo criterio l’autore scivola sul terreno dell’analisi normativa, chiedendosi non come il sistema economico funziona, ma come dovrebbe funzionare. Riassumendo, Graeber fornisce non una ma tre risposte: i lavori “veri” sono quelli che ognuno giudica tali; sono quelli che la collettività considera tali; sono infine quelli che l’intellettuale auspica siano tali. Purtroppo, più risposte tra loro incompatibili non aiutano a capire. Per fortuna, su questa tematica sono disponibili elaborazioni molto più solide. Una argomenta che è produttivo il settore dell’economia che produce qualcosa (di materiale o immateriale) che (direttamente o indirettamente) sia usabile nella riproduzione di tutte le merci, e quindi nell’accumulazione capitalista. Un’altra sostiene che è produttivo il lavoro pagato dal capitale, mentre non lo è quello remunerato dalla spesa del reddito; è quindi improduttivo il lavoro che, esterno alla sfera dei rapporti capitalisti, riguarda la realizzazione del valore aggiunto o il trasferimento di diritti di proprietà su beni e ricchezza[9]. Una terza, infine, unisce le due posizioni precedenti: è produttivo il lavoro che si scambia con il capitale e che è impiegato nella fase produttiva del circuito del capitale, anziché nelle fasi della realizzazione o della finanza[10]. Il tratto che accomuna queste posizioni è che tutte e tre prima costruiscono una teoria del modo di produzione capitalistico, per poi dedurre che sono produttivi soltanto i lavori che rientrano nell’oggetto teorico. Invece di interrogarsi sui requisiti del lavoro “vero” e di quello fasullo, questi approcci classificano i lavori secondo un semplice e coerente criterio in-out: se essi rientrano o meno nei rapporti capitalistici di produzione. In un prossimo articolo, vedremo come tale orientamento metodologico venga riformulato e applicato in un importante libro appena uscito: Il valore di tutto, di Mariana Mazzucato. Concludendo su Graeber, siamo davanti ad un autore che merita sempre di essere letto, essendo tra i pochi capaci di enunciare spunti originali e di attaccare ferocemente gli schemi mentali assodati: due pregi dei quali il suo precedente volume Debito costituisce la migliore manifestazione[11]. Egli tuttavia non s’impegna ad elaborare una teoria del sistema socio-economico contemporaneo, limitandosi a raccontarne la burocratizzazione, a descriverne i comportamenti rapaci, o a forgiare l’etichetta di “feudalesimo manageriale”. In assenza di una teoria, la “economia dei lavori fasulli” colpisce suggestivamente un bersaglio grosso, ma non riesce a spiegarlo. NOTE [1] Cyril Northcote Parkinson, La legge di Parkinson (1958), Etas, Milano, 1980. [11] Vedi Nicolò Bellanca, “Il debito come dispositivo di schiavitù. Una nota su David Graeber”, Jura Gentium, 2013, all’indirizzo http://www.juragentium.org/topics/global/it/bellancagraeber.pdf |