Riandando “da riva a riva” – Ricordando Bachisio Zizi: la scrittura come atto di resistenza e d’amore [di Leandro Muoni]
|
E’ bello professare ed esercitare la critica militante: scoprire, vagliare e segnalare le “novità” letterarie, con piglio non accademico ma “partecipativo” oppure “revulsivo”. Ma altrettanto bello, interessante e utile (se non pure necessario) è ogni tanto volgersi indietro, al passato più o meno recente, con la coda dell’occhio magari puntata sul presente, non ignari dell’attualità (ma quella “vera” che è sempre “inattuale”). E’ così che abbiamo scelto per i nostri lettori di sporgerci e infilare lo sguardo da una “finestra” aperta sulle pagine di un libro apparso agli albori del nuovo millennio (per l’esattezza nel 2001) e che sembra prezioso se non indispensabile per capire la poetica e l’arte narrativa e saggistica di un protagonista delle lettere isolane scomparso alcuni anni fa e forse troppo presto dimenticato o non debitamente ricordato: Bachisio Zizi. Il libro, tragitto o contrappunto di narrativa, saggio di investigazione identitaria, scrigno di memorialistica, dialogo teatrale, frammento di critica letteraria, proposta esistenziale e intellettuale, è intitolato “Da riva a riva” e nelle parole del suo autore vuol essere “istante pregnante della narrazione”, un “aprirsi all’apprendimento dell’ ‘altro’ per dare senso e compimento alla vita, alle cose, alla realtà del mondo che in quest’epoca di trapassi sembra presa in un incantesimo”. Zizi è orunese, e al pari di un altro orunese per appena tre anni di differenza suo predecessore, Antonio Pigliaru, sembra essere, strana circostanza e destino per due uomini appartenenti alla storia e memoria di un paese dalla reputazione talvolta controversa di ambiente dalle chiusure gelose ed etnocentriche a causa delle proprie traversie socio-culturali; sembra essere – dicevamo – invece autore e artefice di transizioni, di passaggi, di ponti, di scambi di saperi: appunto traghettatore di traversate o attraversamenti “da riva a riva”. Entrambi nocchieri di popoli che portano sulle spalle il peso di una sorte matrigna, di un fato avverso, nocchieri ricolmi di “buona volontà” e confortati dal sostegno della coscienza popolare. Come nocchiere e traghettatore era stato, con la sua aspirazione a trascinare tutto un popolo (così notava efficacemente Mario Ciusa Romagna) dietro di sé, agli albori del secolo scorso, il più grande poeta sardo: Sebastiano Satta. Altro barbaricino stanziale, spesso incompreso oltre confine, al di là dal mare, appunto perché scrittore atipico, dalla difficile catalogazione, in quanto esteticamente, culturalmente e filologicamente, in una parola storicamente “confinato fra due secoli” (l’Ottocento e il Novecento) come l’ha rappresentato la critica più avveduta, ma abitato o meglio visitato dal demone delle trasmigrazioni del sogno verso la novità di un esterno ignoto: che era poi il suo miraggio perturbante, l’ermetica fata morgana e l’enigmatico presentimento o balenio della incipiente modernità nell’arcaico mondo dei re pastori. Quel Sebastiano Satta che è, a ben vedere, il capostipite e l’archetipo della musa segreta di tutti i poeti sardi novecenteschi (anche quelli che ne sembrano apparentemente più distanti) e della loro lacerante condizione fantasmatica. Spesso adombrata da una tristezza secolare tanto idiopatica quanto antropologica. Ma la tristezza di Zizi non è mai “demoniaca”, nel senso di una forma, di uno stigma tipico del mondo rappresentato nel “Giorno del Giudizio” come quello di certa Nuoro sattiana (del secondo Satta, Salvatore). Al contrario è una tristezza aperta, se così si può dire, e fattiva, curiosa del nuovo, attenta e applicata all’empiria, mirante al progetto. Il discorso o il fluire e refluire “da riva a riva” prende le mosse dai “luoghi dell’anima”. Procede da quella “nuoresità” rivendicata o forse meglio rievocata con tremore introspettivo e con dolente meraviglia o commozione e struggimento sentimentale dallo scrittore. La Nuoro dell’infanzia e adolescenza dell’autore, del piccolo orunese, agli occhi dei biddajos come lui, ovvero gli abitanti dei paesi del circondario che allora cominciavano a invadere la città quasi furtivamente, appare quale luogo non ostile ma neppure familiare bensì perturbante e tuttavia attrattivo, quasi magnetico: “A Nuoro non si giungeva mai in pieno giorno, come se i fuggiaschi cercassero i crepuscoli per nascondere il loro disagio”. Quella Nuoro che però “cominciò a perdere la sua anima quando divenne capoluogo di provincia”. Perché allora “da luogo di scambi e di mediazioni decadde a luogo di transito e di fughe”. Una Nuoro ben presto idealizzata nell’immaginario del futuro scrittore ancora adolescente, che la vedeva in controluce come ateneo della dialettica dello spirito comunitario, arengo delle “discussioni interminabili” e irrequiete. Discussioni in realtà ebbre e solitarie di intellettuali senza autentiche appartenenze vecchie e nuove né vincolanti deleghe o mandati, bensì balenanti con licenza magari dagli stranianti fumi del “delirio” alcolico. Astrattamente creative e amaramente ironiche. Procedenti di pari passo con la trasformazione o meglio involuzione del volto della città di provincia, dove l’antico decadeva e il moderno stentava a insediarsi: “ Fu proprio nel passaggio da un’economia incentrata sulle terre e sul gregge a un’economia monetaria che Nuoro si smarrì”. E’ l’analista economico e finanziario che parla attraverso le vedute critiche dello scrittore. Zizi ha sempre rivendicato la profonda compenetrazione della sua attività di uomo di lettere con la sua professione di dirigente bancario. La sua arte narrativa non avrebbe mai visto la luce senza la “complicità” e la “cooperazione” di queste due polarità complementari. Così, per rispondere e attuare un’azione di contrasto allo “smarrimento” del tessuto economico e socio-culturale del capoluogo di provincia barbaricino, Zizi intraprende un sentiero arduo e aleatorio, forse destinato allo scacco di una sperimentazione magari imperfetta o incompiuta: quello di una riappropriazione e una apologia del sapere antico, ovvero del cosiddetto bagaglio tradizionale di “su connottu”, l’experimentum crucis tante volte citato e iterato retoricamente e improvvidamente da molti corrivi o superficiali interpreti della storia della mentalità. Come pure quello della reinvenzione e reinvestimento di tale asse patrimoniale, per tanti aspetti così fantasmatico e al contempo residuale, nella realtà circostante alla luce dell’innovazione. Certo Zizi non si allinea alla schiera degli apologeti semplicisti, dei laudatores temporis acti. Egli sa benissimo che il salto dal pre-industriale al post-industriale non si può realizzare impunemente a scapito dell’attraversamento della modernità e delle sue fasi, strati e stadi culturali. Resta tuttavia la generosità della premonizione e il coraggio dell’ammonimento, della proiezione e dell’ipotesi, se volete dell’utopia: “Dobbiamo inventare altre forme di circolazione delle idee; dobbiamo riappropriarci creativamente delle nostre risorse materiali e morali”. Insomma “dobbiamo avere il coraggio di ripensare tutto, traducendo le lingue e il sapere del mondo in nuorese”. Zizi si propone al pubblico nel vario e coerente articolarsi della propria attività letteraria di narratore, sempre legata alla forma realistica e all’impegno sociale secondo la solida tradizione di un filone assai frequentato nella letteratura del Novecento: di lui si ricorderanno almeno il romanzo d’esordio “Marco e il banditismo”, “Il ponte di Marreri” “Erthole”, e il “malfatato” o dovremo dire più correttamente “ingiustamente malfamato” “Santi di creta”, incredibilmente sottoposto a sequestro dalla magistratura per diffamazione dietro denuncia e querela di parte, caso da annoverarsi tra le disparate tipologie di censura nella tradizione delle lettere sarde, ma forse esemplare più unico che raro nella sua fattispecie penale. Quel “Santi di creta” che è divenuto “opera al nero”, alchemica e innominabile, e che costituisce una sorta di prolungamento, quasi un’appendice del “Giorno del Giudizio” sattiano. E che ha contribuito con i suoi modelli antecedenti e susseguenti a fare di Nuoro uno dei territori privilegiati della topografia o geografia letteraria del Novecento non solo sarda ma italiana e in definitiva universale. E poi vorremmo ricordare qui anche il romanzo “Cantore in malas”, piccolo grande gioiello di narrativa “etica” e “itinerante”, fondamentalmente esperienziale ed esistenziale, che si è aggiudicato il “Premio speciale della giuria” nel concorso letterario “Giuseppe Dessì”, edizione 1998. Ma vorremmo proseguire e concludere con la sezione intitolata “Porrogos” (ovvero interrogatori) costituita da alcune interviste allo scrittore e dal suo dialogo immaginario con Salvatore Satta, intitolato “Virtualità nuorese”, e composto da un preludio e da tre quadri. Tutto ciò, dopo aver citato almeno alcuni interventi particolarmente significativi su Antonio Pigliaru, Salvatore Mannuzzu e Giaime Pintor, autori di risentita moralità e alta coscienza civile, ciascuno per la parte di sua competenza e per il suo tratto di carattere, per la sua lezione. Inoltre segnaliamo le recensioni di poeti: tra cui Raimondo Manelli e Lucia Pinna (autrice tra l’altro di un libro in limba ovvero di una toccante raccolta di versi pervasi di dignità, “Alenu ‘e radichinas”, pubblicato dalla stessa editrice ziziana, la Cosarda, dopo “Da riva a riva” quale anello della collana o del trittico di un dialogo fra amici e sodali comprensivo dell’amaro epperò convincente libro di riflessioni sul proprio tempo e sulla propria interiorità intitolato “Lunga ancora la notte” di Giovanni Dettori). Ancora da segnalare la felice incursione dell’autore nelle arti visive a proposito di un apprezzato volume, ricco di una nutrita galleria di caricature, “Come la luna”, del poliedrico artista cagliaritano Giancarlo Buffa. Nell’intervista rilasciata al giornalista Roberto Paracchini, che incalza lo scrittore sulla sua doppia appartenenza alla letteratura impegnata e al mondo degli affari e della finanza (ricordiamo che l’”oscuro”, riservato e irreprensibile orunese è stato anche un importante dirigente bancario), alla domanda se lui “non ha mai pensato, magari in un momento di sconforto, di ritirarsi nel suo paese e di dedicarsi solo alla scrittura”, Zizi risponde fieramente: “Il ritiro è fuga, disimpegno, disarmo morale, e io sono uomo di princìpi, temprato dalla vita dura che ho vissuto”. E così soggiunge, a maggior gloria dell’umanità del “fare”: “Non credo poi di riuscire a scrivere niente nell’ozio. Le cose migliori le ho scritte nei momenti in cui sentivo più acuto il disagio del vivere”. Che è poi una professione di stoicismo, uno stoicismo “fragile” ma pur sempre autentico stoicismo o magari un più temperato, austero e conseguente epicureismo lucreziano. La concezione della scrittura era in Zizi quella di un atto di “resistenza”, di opposizione all’avversa sorte: un qualcosa di simile, nella sua originaria derivazione da una mentalità popolare e antropologica di radice barbaricina, all’imperativo di resistere agli insulti e alle prove, alle strettoie “de s’apprettu”. Ed è indubitabile che la scrittura sia in lui classicamente un “farmaco”, come testimonia alla perfezione il suo ultimo straziante libro, “Le dolenti cure”, scritto in uno dei momenti più bui della vita dell’autore, in seguito alla morte dell’adorata consorte Maria. Una cupa meditatio mortis, un monologo sull’oscurità che non ci peritiamo di definire tra i più intensi e assoluti della letteratura italiana contemporanea. E poi c’è quell’ardito confrontare e comparare il “grande” con il “piccolo”, come quando lo scrittore afferma di voler applicare al minor caso sardo la maggior lezione storiografica di Fernand Braudel a proposito dell’”Identità della Francia”, rapportandola all’amata scala e sponda isolana: “Io vorrei percorrere la stessa strada di Braudel, domandandomi innanzitutto se esista una entità Sardegna, definita e definibile in tutte le sue espressioni, capace di porsi e imporsi come polo dialettico in un confronto con il resto del mondo”. Resistenza che s’intreccia con un altro “momento” e “dimensione” dello spirito, o se si preferisce dell’anima, della psiche, il sentimento dell’amore: “La mia passione per la scrittura nasce da un disperato bisogno d’amore”. Un amore che è passione degli uomini e anche dei libri, come attesta il capitolo del libro dove il nostro autore ragiona e riflette sulla dotazione della “Mia libreria”: ricca di un ordinato e canonico archivio di memoria, vero compendio del sapere della civiltà europea e in genere occidentale, ma più propriamente e veridicamente universale, che prende le mosse e l’abbrivo dal ricordo infantile della raccomandazione paterna di leggere “onzi canticheddu ‘e papiru iscrittu”, lui figlio di uno scalpellino, di un cavatore di pietre che avrà la ventura e l’ingegno di approdare all’empireo dei dotti. La vita morale e intellettuale, anche e soprattutto nell’esercizio della funzione letteraria e della professione finanziaria, è stata per Zizi una ”lotta accanita” per “non diventare un uomo a una dimensione”. E qui lo scrittore, dopo aver respinto lontano da sé lo scenario e il meccanismo unidimensionale (l’appiattimento della “repressione tollerante” di un’umanità passiva perpetrato dalla società industriale e consumistica) già analizzato e denunciato da Marcuse, si affida al proprio genio personale, al proprio daimon razionale, geometrico e matematico: “Fra i due fuochi della mia ellisse (rispettivamente il paese e il resto del mondo, ndr), che non si incontrano mai, ho cercato e continuo a cercare un terzo fuoco, lo spazio perduto di cui nessuno parla”. E conclude, con la forza d’attrazione della gravità terrestre e degli annessi nutrimenti, evocando il mistero di tale spazio perduto (lo spazio infinito del possibile, ndr), che fomenta ed esalta l’attaccamento primario, materno (è singolare e sintomatico in Zizi il rispetto e quasi la venerazione per la donna e la funzione femminile nella storia); evocando il mistero – dunque – e appellandosi alla propria insuperabile isolanità o insularità: “Tutto ciò rafforza i miei legami sentimentali con la Sardegna, che mi possiede in ogni fibra, e non solo metaforicamente”. Nell’intervista o dialogo immaginario con Salvatore Satta, l’autore si autorappresenta come “animato da furori tecnologici” e riguardo alla sua avventura o esperimento dialogico in absentia afferma: ”Volevo collocare l’eroe della mia intervista nelle rotte del cyberspazio”. Qui “ogni esperienza vissuta e pensata può essere trasposta in un percorso di realtà virtuale”. Questa navigazione della e nella realtà virtuale può far pensare che Zizi intenda bypassare lo stadio specificamente moderno di civiltà nel passaggio o meglio nel salto dal pre-moderno al post-moderno come nell’utopia del cosiddetto “villaggio elettronico”, applicata alla condizione comunitaria e comunicativa della Sardegna del tempo presente e prossimo venturo, quale si ipotizza nel paradigma culturale etnocentrico teorizzato a suo tempo da Michelangelo Pira. Zizi non ritiene inutile o dannosa la modernità. Anzi la considera un necessario passaggio dialettico del processo storico: una sorta di scommessa onde realizzare un “laboratorio di idee per pensare e fare in sardo”: facendo propri i valori di libertà di pensiero, di impresa, di giudizio e di parola. Qualcosa che invera ma anche trascende il puro e semplice “villaggio elettronico” (variante locale e minoritaria del più noto “villaggio globale” di mcluhaniana memoria). Nel dialogo con l’ombra austera e paterna di Salvatore Satta trapela il dolore dello stesso Satta per la celebrazione di un vero e proprio “processo” istruito nei suoi confronti da parte di un’intera realtà e comunità sociale, culturale, da un’assise popolare, quella del suo paese: “Ma il processo – afferma Boboreddu, ovvero l’autore del “Giorno del Giudizio” nella versione drammatica e resa dialogica di Zizi – il libro l’ha subito e io con lui, un processo celebrato nelle piazze dell’Atene sarda”. Il “risentimento degli uomini” di un’intera comunità, della tribù levitica, “duole” amaramente allo scrittore imputato di lesa maestà patria. E qui è Bachis (Zizi) che pronuncia l’arringa difensiva a favore di Boboreddu, interpellato nella terza persona di cortesia: “Le duole l’accusa lanciatale da un pulpito altissimo di aver parlato male di tutti: di suo padre, di sua madre, dei suoi fratelli, dei suoi zii, dei pastori, dei signori, degli avvocati, dei politici, dei preti, dei canonici, dei cappellani…”. Si avverte chiaramente in queste parole accorate l’amarezza del nostro autore per una vicenda personale segnata da una sorte analoga: quella per cui anche al suo romanzo “Santi di creta” – come già ricordato – fu riservato un simile trattamento: un trattamento “processuale” (ma questa volta a seguito di querela di parte e non di un’”accusa” collettiva, comunitaria, cosa che rende ancor più amara e cocente la vicenda per l’”imputato”), un trattamento e una condanna non solo moralmente censoria ma anche obbiettivamente tipica di un verdetto da camera di consiglio penale. In questo dialogo, intervista o interrogatorio metafisico fra i due autori, l’uno in guisa di maestro o di grande anima e l’altro nei panni del discepolo e dell’interrogante, aleggia tutta la mentalità antropologica barbaricina (“i nuoresi – commenta Boboreddu – hanno una particolare vocazione per i processi”) e qui il Satta si inserisce e si associa al cuore della sua gente in una medesima attitudine cognitiva e comportamentale: “forse è per la mia nuoresità che il ‘processo’ ha finito per diventare rovello letterario e scientifico della mia esistenza”). Questa passione per il “processo” e per i suoi fondamenti, miti e riti e semiosi è frutto di una predisposizione o vocazione giuridica dell’autore del “Giorno del Giudizio” a considerare e fondare una personale teoria del “mistero del processo”. Un “mistero” legato alla categoria e alla casistica del “giudizio”. Un “mistero” che sembra perfino contenere vibrazioni kafkiane, nel senso che adombra una connotazione in qualche modo “senza scopo”, “inumana”, “misteriosa” (sono termini del Satta) appunto nell’atto e nella categoria del “giudizio” , che sembra potersi ricondurre a una attitudine psicologica di tipo staremo per dire “sadico” (il sadismo del gusto della crudeltà sotto le specie del sarcasmo, che contraddistingue la prosa sattiana) e che sottende l’analisi giudiziaria e il verdetto penale e finale: “Si direbbe che tutta la pena è nel giudizio – sono parole dello stesso Satta tratte dal “Mistero del processo” – che la pena azione, il carcere, il carnefice, interessino soltanto in quanto sono, per così dire, prosecuzioni di giudizio (si pensi al termine giustiziare)”. Variante barbaricina su un altro fronte, quello di un ipotetico psicodramma, del cosiddetto “teatro della crudeltà” artaudiano, sadico questa volta in maniera non esclusiva: “La crudeltà è prima di tutto lucida, è una sorta di lucido controllo, di sottomissione alla necessità”… “C’è nell’esercizio della crudeltà una sorta di determinismo superiore cui perfino il carnefice-seviziatore è soggetto e che, all’occorrenza deve essere determinato a sopportare” (Antonin Artaud, “Il teatro e il suo doppio”). Quel “sadismo” che è implicato e sotteso nelle memorabili pagine del “Giorno del Giudizio”, in cui lo scrittore si concede l’amaro piacere o voluttà di definizioni e giudizi taglienti e crudeli, sarcastici e urticanti, inferti con un pathos freddo e sentenzioso, quasi aforismi di una morale antica e patriarcale, veterotestamentaria. Orbene, il tratto della “crudeltà” è assente in Zizi, in questo straordinario e atipico orunese, in questo “cantore del miele perduto” (come lui definiva Salvatore Cambosu: con formula valida anche per sé, chioseremo noi); straordinario e atipico orunese che è invece personalità più conciliante, intermediatrice e affettiva di Satta, ispirata al principio del “gadameriano ‘circolo ermeneutico’”: si potrebbe affermare che si trova in lui una sorta di mitezza, nel senso chiarito da Norberto Bobbio di “non-violenza”, “tolleranza”, donazione”. Forse doti che si coniugavano nel nostro autore con un basico, lungimirante e aperto “liberalismo ideologico” (per citare una formula di Gianfranco Murtas). Un liberalismo però simile a un umanesimo gentile, se così si può dire: a suo modo competitivo ma al tempo stesso inclusivo. Ecco, l’arte poetica di Bachisio Zizi si caratterizza così: come donazione, atto d’amore e di resistenza al destino. |
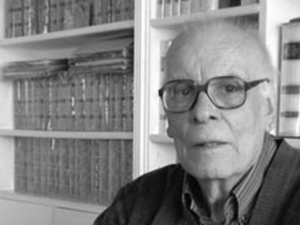
Titia!…
A nois Sardos, sos ‘bonos’ e fintzas sos ‘malos’ (deo so in custa segundha categoria) nos at furminadu s’italianu (Italianu). Tiat tocare de nàrrere “Pisti! Pistidha!” (chi, antzis, sos lampos, o rajos chi siat, bochint e brúsiant, lu faghent a carbone a unu).
Ma namus Titia! No est cosa chi nos caentat su coro (si sos furminados ndhe zughimus ancora).