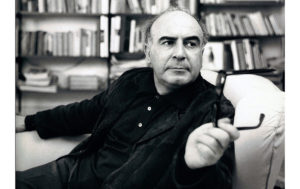Giuseppe Dessì: “Come sono diventato scrittore” – Il racconto di una vocazione letteraria (e dintorni) [di Leandro Muoni]
|
“Come sono diventato scrittore” è il titolo di una memoria narrativa dal carattere autobiografico di Giuseppe Dessì pubblicata tre anni prima della sua morte, avvenuta nel 1977, su una rivista romana e successivamente inclusa nel volume “Un pezzo di luna – Note, memoria e immagini della Sardegna”, edito dal Banco di Sardegna con la curatela di Anna Dolfi, massima studiosa e storica conoscitrice dell’universo poetico dessiano, e ora presentata in una gradevole plaquette uscita per i tipi di Henry Beyle come “esemplare per gli amici del Premio Dessì”. Il succoso articolo vede la luce nella collana Lynotipe di “testi brevi, inediti o rari” e vi esce preceduto in elenco dagli scritti squisiti di Nigro, Stendhal, Bulgakov, Consolo, Comisso, Sciascia, Vigevani, Zweig e Campanile. A conferma della qualità e caratura europea dell’autore sardo, uno fra i maestri della letteratura non solo isolana ma anche e soprattutto italiana, vincitore tra l’altro del Premio Strega per l’anno 1972 con il romanzo “Paese d’ombre”. “Come sono diventato scrittore” racconta il processo dell’avvicinamento da parte dell’autore alla scrittura letteraria e le fasi della sua rivelazione: “Mi hanno chiesto come sono diventato scrittore. E’ una domanda intima, personale alla quale è difficile dare una risposta esauriente”. Già questo tratto di discrezione e prudenza o cautela mostra tutta la riservatezza e quasi il culto dell’interiorità professato dallo scrittore sardo, che sembra qui tradire o meglio richiamare e confermare la sua condivisione con una certa indole antropologica isolana di reticenza e autocontrollo riguardo alla mozione degli affetti privati. Ma per uno scrittore di razza gli affetti privati sono anche occasioni di scavo dentro le verità e ragioni profonde della creatività artistica. Dunque Giuseppe Dessì incomincia il suo resoconto autobiografico, secondo una collaudata tecnica tradizionale, con un aurorale affondo nel tempo dell’infanzia e fanciullezza: ”Da bambino, quando non viaggiavo al seguito di mio padre, che era ufficiale di carriera e si spostava spesso da una guarnigione all’altra, abitavo con mia madre e mio fratello minore in casa del nonno, a Villacidro, un grosso borgo rurale della provincia di Cagliari, ai piedi della catena montuosa del Linas”. Già in queste parole si riscontra in nuce tutto il contenuto del mondo poetico dello scrittore. La peregrinazione e la confermazione di questo precoce e iniziatico “viaggio in Italia” al seguito del padre avrebbero generato e fortificato nel giovane Giuseppe quel tratto di coscienza e conoscenza nazionale e più precisamente patriottica tipico del suo carattere. Poi la convivenza e la vicinanza della madre e del “paese”, il “grosso borgo rurale”, avrebbero esercitato la funzione complementare del legame con la dimensione più segreta e profonda del fattore affettivo e dell’impulso poietico dell’autore: la dimensione del “nido”, dell’intimità, dell’eterno femminino (le donne rappresentano nell’universo dessiano le vere custodi e nutrici di un misterioso “alfabeto” identitario), insomma dell’istanza materna e dell’ombra riparatrice domestica ancorché perturbante: il “paese d’ombre”. La funzione domestica è ulteriormente sviluppata nelle parole che seguono: “La casa era grande, piena di zii, zie, cugini e gente di passaggio. Era il centro della grande azienda agricola che il nonno era riuscito a mettere assieme grazie alla sua abilità, alla sua capacità di lavoro e a una certa fortuna che brillò in quella casa finché lui visse”. Pagina dove pare di percepire con qualche variante l’eco dell’iniziazione e inaugurazione della “casa” nell’incipit del romanzo autobiografico postumo di Grazia Deledda: “Cosima”. Il culto della “casa”, il rito della quiete e accoglienza domestica e il contorno della connessa relativa agiatezza di una modesta borghesia rurale, sono i segni distintivi che accomunano i due scrittori: Dessì e la Deledda. Anche se Dessì manterrà un atteggiamento ambivalente e diffidente nei confronti della scrittrice sua conterranea e peraltro “ingombrante” Premio Nobel. Il contatto prende le mosse da un’iniziale riserva e sospetto (“L’avevo letta e, per mio conto, criticamente sistemata”, sottilmente ironizza nell’articolo piuttosto severo e riduttivo, intitolato “Il verismo di Grazia Deledda”). La valutazione restrittiva si sarebbe poi parzialmente allargata e stemperata in un successivo articolo dal titolo “Grazia Deledda cent’anni dopo”, conservando comunque un accento non proprio propenso alla ritrattazione e al risarcimento. Ma che a leggerlo pensosamente a distanza di anni appare a suo modo un atto cavalleresco di cortesia, quasi un omaggio o il riconoscimento dell’onore delle armi. Scrive il Dessì: “La Deledda scrittrice si identifica naturalisticamente con la Sardegna, non con una Sardegna idillica e turistica, ma con la Sardegna nuragica e pastorale in cui vive ancora la preistoria. Grazia Deledda è un pezzo di Sardegna fuori del tempo e della cultura italiana, una Sardegna che ha un suo senso del tempo e dello spazio nel quale è difficile penetrare e che negli italiani ha sempre generato diffidenza e incomprensione”. Ma occorre notare in questo passaggio sintomatico che, a dispetto delle stime o valutazioni delle qualità deleddiane non proprio “progressive”, anche nel nostro autore è presente e figura col suo portato di valori e stratigrafie di senso l’elemento archeologico e staremo per dire ontologico della “preistoria”, già operante nella Deledda, non più però sotto le parvenze del ”mito” come nella scrittrice nuorese, bensì questa volta in quanto “scoperta” della realtà profonda e fenomenologica e luogo delle percezioni della coscienza. Scrive Dessì nella “Scoperta della Sardegna”: “Può accadere a chiunque, in Sardegna, di scivolare fuori dal tempo storico attraverso le cose, attraverso la materia di cui sono fatte le cose (…) La tentazione di sfuggire al tempo storico europeo qui è continua (…) Perciò, se penso agli uomini, li vedo come formiche o api, li vedo come specie che dura immutata nei millenni. Una continuità nella quale bisogna includere anche la morte che unisce una generazione all’altra. E’ in virtù di questa continuità che la preistoria vive in Sardegna”. Continuando ora nella ricostruzione autobiografica del “Come sono diventato scrittore”, l’autore evoca i suoi bei dì allietati dai giochi infantili, quando “Noi ragazzi godevamo di una libertà quasi illimitata”. E così prosegue: “Poco lontano dalla casa di abitazione era la casa rustica, della il ‘mulino’ perché ci stava il frantoio per le olive (…) Il mulino, che avrebbe dovuto esserci interdetto, era, in realtà, il nostro campo dei giochi”. Questo campo dei giochi era lo scenario dove i ragazzi e gli amici del futuro scrittore giocavano agli ‘indiani’ e ai ‘visi pallidi’, dove egli si attribuiva il ruolo di capo della tribù indiana, tratto che già lo contraddistingueva per quel suo precoce parteggiare per le minoranze se non anche maggioranze oppresse, cioè gli strati più vicini alla terra in quanto espressione dei bisogni e delle ragioni dei ceti popolari, che avrebbero attivato l’impegno civile del nostro autore e in qualche misura la sua stessa meditata militanza politica nelle file della sinistra, da ultimo come indipendente nelle liste del P.C.I. e infine iscritto a questo partito. Lui per natura e vocazione di estrazione liberalsocialista. Questo vivere a contatto con la realtà contadina e in genere con il popolo della campagna l’avrebbe segnato e accompagnato nella sua attività professionale e politica ma soprattutto nelle sue “scelte” morali ed estetiche, nei suoi orientamenti letterari e di poetica (“scelta”, parola e idea dessiana quant’altra mai, cui lo scrittore dedicherà un libro così intitolato che vedrà la luce postumo): “Credo che il fatto di aver vissuto in campagna da bambino abbia contribuito a rendere la realtà più accessibile alla mia conoscenza”. Perché “La comunità intorno a me, questa vita sociale di cui ho cercato di dare un’idea, faceva come da cassa armonica ai miei sentimenti, ingigantiva e al tempo stesso mi permetteva di percepire e di partecipare ai sentimenti degli altri”. Qui sta il nocciolo o la radice del realismo ovvero del naturalismo del nostro autore, la sua attenzione ai problemi e ai lieviti storici e sociali, alla stessa cultura materiale e al sentimento delle classi sia dirigenti che subalterne, che costituirà il carattere dominante, lo stigma non solo contenutistico ma anche stilistico del suo linguaggio letterario. Che tra l’altro si coniuga nella sua opera con l’altro aspetto caratterizzante: quello della percezione del profondo, della vita sotterranea, del sottosuolo, insomma quello già accennato della “preistoria”. Abbinamento e anzi compenetrazione che costituirà il pregio maggiore della sua arte narrativa: sospesa o meglio innervata tra naturalismo o realismo e psicologismo. Spartita tra Flaubert e Proust, secondo quanto indicherà la critica più avvertita. Come si può verificare e constatare in opere che prediligono la forma del racconto psicologico: ad esempio “San Silvano”, fra i suoi testi più proustiani, e romanzi quali “Il disertore” o lo stesso “Paese d’ombre”, capolavori di realismo: ma un realismo sempre intriso di memoria o di sentimento del tempo e dello spazio interiori. Sempre sul versante dei giochi e della parentesi ludica della fanciullezza, Dessì rievoca e suggerisce queste premonizioni e anamnesi: “Tra i nostri giochi ce n’era uno che mi introdusse gradualmente alla pratica dello scrivere”. Si tratta del disegno, della passione per l’arte visiva: “Ero un pessimo scolaro, ma mi piaceva disegnare. Con pochi tratti ero capace di schizzare persone, animali, alberi e case”. E qui si introduce un altro aspetto, laterale ma non meno degno di attenzione, della personalità artistica di Giuseppe Dessì: la sua passione per la pittura. Una passione precoce e poi maturata e coltivata negli anni, che gli fa creare dipinti e quadri interessanti, in rapporto subliminale col gusto del tempo perduto e ritrovato, con un senso del fare pittorico legato alla migliore tradizione otto-novecentesca, specie impressionistica o post-impressionistica ed espressionistica. Gustoso a tale proposito l’episodio delle prodezze disegnative del piccolo Dessì, dell’autore da cucciolo, quando aveva dato vita a un giornalino artigianale illustrato, assai apprezzato e seguito dal nonno nelle sue varie puntate, il quale però era rimasto alquanto perplesso “davanti all’illustrazione in prima pagina, dove era rappresentata la fucilazione della famiglia imperiale russa” che il piccolo Dessì “aveva copiata pari pari dalla ‘Domenica del Corriere’”. Risultato: “il nonno mi invitò a non occuparmi di politica”. Sempre fra i segreti, le iniziazioni e i “misteri” della casa padronale di famiglia, nel tempo avventuroso dell’infanzia e adolescenza, è memorabile l’episodio narrato dall’autore del ritrovamento fortuito della “biblioteca murata” nelle pareti della austera magione, avvenuto casualmente e inconsapevolmente. Una biblioteca dove il futuro scrittore avrebbe trovato “i primi veri libri della mia vita”. Fra questi: “’L’origine della specie’ di Darwin, il piccolo ‘Compendio del Capitale’ di Carlo Cafiero, una pessima traduzione de ‘I miserabili’ di Victor Hugo e altri libri che nessuno si sarebbe mai sognato di mettermi in mano”. Annota Dessì: “Io li lessi senza capirci un gran che”. Doveva trattarsi di libri in buona parte di estrazione materialistica o illuministica, ma anche positivistica. Probabilmente di matrice ideologica radicale e massonica. Fu con questo eterogeneo bagaglio di letture malcomprese e maldigerite, autodidattiche e farraginose che il nostro autore si iscrisse e si presentò al liceo “Dettori” di Cagliari, dove fu notato dal professore di storia e filosofia, che allora era niente meno che Delio Cantimori, il futuro grande storico dei movimenti ereticali italiani ed europei. Di lui Dessì ci avrebbe lasciato in seguito un ritratto sobrio, commosso e riconoscente, attraverso un pregevole testo di saggistica memoriale, dove individuava tra l’altro il “professore di liceo” come uno dei suoi maestri di antifascismo incipiente e ancora clandestino, ma già allora in qualche maniera resistente. Facendo qualche passo a ritroso, sempre a proposito dell’itinerario formativo del nostro autore, apprendiamo che “quando, per consiglio del mio professore di liceo Delio Cantimori, mi mandarono all’Università di Pisa, il fatto di aver letto quei libri diventò assai importante”. E infatti “Fu a Pisa che scrissi i miei primi racconti veri”. Così prosegue la memoria narrativa: “Quando ne ebbi tanti da fare un volume il mio carissimo amico Claudio Varese prese a stamparlo a spese sue e degli amici”. Il libro si intitolava “La sposa in città” e fu pubblicato dall’editore Guanda nel 1939. Qui sopra si allude a quegli encomiabili personaggi o personalità letterarie che lo stesso Dessì chiamò i suoi “maitres-camarades”: il già citato Claudio Varese, Claudio Baglietto, Carlo Ludovico Ragghianti, Aldo Capitini, Carlo Cordiè. Furono proprio loro, unitamente agli autorevoli e favorevoli recensori del narratore sardo quali Silvio Benco, Pietro Pancrazi, Gianfranco Contini, ai quali va aggiunto in posizione privilegiata il più giovane Giorgio Bassani, che contribuirono a stimolare nell’animo e nella mente dell’isolano Giuseppe Dessì quel sentimento di legame culturale, morale ed estetico con l’Italia e la sua civiltà, in ideale prosecuzione e potenziamento del formativo apprendistato dei suoi numerosi viaggi attraverso la Penisola compiuti in compagnia e a seguito del padre ufficiale. Un legame culturale e sentimentale che forgerà la concezione di Giuseppe Dessì dell’italianità innestata nella sardità. “Ci sono molti modi di essere italiano – scriverà – o di arrivare ad esserlo”. In realtà tali modi sarebbero dati dalla “strada che ogni italiano percorre, dal cuore della propria provincia fino a quell’ideale paese dell’anima che è l’Italia unita, cioè dal dialetto alla lingua, alla cultura nazionale, o per lo meno alla koinè (…) che poi è quella che il Foscolo (…) chiamava lingua ‘mercantile’ o ‘itineraria’”. Ma per il parlante sardo – osserva ed eccepisce Dessì – il discorso dell’italianità assume contorni particolari e specifici, differenti: “Il dialetto che parla (dovrei dire anzi i dialetti) non è un dialetto italiano, ma, come scrive Wagner, una lingua romanza indipendente”. “Il sardo – prosegue l’autore – ha un modo diverso di essere o diventare italiano”. Tra sardità e italianità “vi è un taglio netto, un salto”. E insomma “Non è esagerato dire che, per il sardo, l’italiano è una lingua adottiva”. In parole povere “straniera”. Per utilizzare da parte nostra una formula felice e di portata più ampia, coniata per proprio conto da Joyce Lussu, tale tipo di relazione adottiva s’instaurerebbe secondo l’immagine metaforica de “L’olivastro e l’innesto”. Ma in verità quest’idea di “adozione” è quella che fa del rapporto con la civiltà italiana un rapporto complesso di amore-odio. Perché, pur nutrendo una forma di risentimento nei confronti del “continente”, della “penisola”, “nessun sardo accetterebbe di essere considerato ‘straniero’ in Italia, ed io uso questa parola ‘straniero’ in senso tutto particolare, ben lontano dal negare l’italianità dei Sardi”. In effetti il nostro autore intende soltanto insistere sull’affermazione di un contrasto, di un argine frapposto alla “solita retorica nazionalistica”, ritagliata a livello e misura non solo regionale. Posizione che poi combacia in qualche modo con lo stesso atteggiamento multilaterale e pluralistico di chi, mutatis mutandis, autorevolmente alla dizione “letteratura italiana” preferisce sostituire quella, attenta non solo alla storia ma anche alla geografia, di “letteratura degli italiani”, alludendo appunto all’idea dell’unità nella pluralità. Insomma per i Sardi la questione della composita unità culturale e politica della repubblica è un problema che attiene alla “scelta” (abbiamo già sottolineato l’importanza emblematica ed estensivamente ideologico-culturale di questo concetto nel pensiero dessiano). Potremo introdurre qui sempre sul versante delle scelte l’interessante avvicinamento e la conseguente commistione linguistica e stilistica operata fra i due codici espressivi, sardo e italiano, in vigore nell’attività letteraria degli scrittori isolani del nostro tempo. Che anzi procede in direzione collaborativa e inclusiva nell’ambito di uno colorito italiano regionale o federale (anche se talvolta scade negli esiti modaioli di uno stucchevole manierismo maccheronico). E dunque suffraga e avvalora alla prova dei fatti la “scelta” nel senso paradigmatico di Giuseppe Dessì. Una scelta in questo caso ancora una volta unionistica e non separatistica. Recentemente è stata diffusa una notizia giudicata eclatante sulla stampa regionale, relativa al ritrovamento di un breve testo in lingua sarda, preceduto da una premessa in lingua italiana, sulla figura di Eleonora d’Arborea, a firma Giuseppe Dessì e stampato da una oscura tipografia locale, per la precisione oristanese, nei primi Anni Cinquanta, ben prima che lo scrittore pubblicasse, nel 1964, presso un grande editore nazionale il suo “racconto drammatico” “Eleonora d’Arborea”, scritto in lingua rigorosamente ed esemplarmente italiana, come del resto l’intero corpus della produzione letteraria dessiana. Tale notizia aprirebbe un varco precoce in direzione della pratica rivendicativa di un “bilinguismo perfetto” anche nelle pagine dello scrittore forse più “italiano” della letteratura sarda. Adducendo le prove di un interesse e un’attenzione fino ad oggi ritenuti improbabili da parte del nostro autore per la scrittura in limba di proprio pugno e propria scelta. Come a dire che l’esempio del Dessì “ritrovato” potrebbe, nei disegni di certuni, costituire il pretesto per considerare eventualmente superate le motivate obiezioni per cui l’autore non debba acquisirsi necessariamente di diritto al partito di quanti pretenderebbero che il premio a lui intitolato venga destinato anche alle opere redatte in lingua sarda. Tentativo peraltro già avanzato, senza le novissime e finora inedite “pezze giustificative”, e tempestivamente respinto in anni precedenti dai responsabili del premio stesso, perché ritenuto frutto di una presa di posizione strumentale. Insomma, un’ipotesi, un disegno non in linea con l’intestazione e destinazione nazionale del Premio. Né col principio della libera scelta, dell’autonomia in tutti i sensi, non solo a geometria variabile. E’ infatti come se – volendo azzardare una provocazione – si proponesse per converso al Premio “Città di Ozieri” di istituire una parallela sezione riservata necessariamente alle opere redatte in lingua italiana. Tanto per rispettare e attuare il bilinguismo perfetto. Sono ad ogni buon conto in corso indagini per appurare l’autenticità e veridicità dell’attribuzione all’autore di “Paese d’ombre” del testo “anomalo” e per così dire “clandestino” dell’”Eleonora d’Arborea” rediviva in limba, quasi un hapax legomenon nella produzione dello scrittore, da parte della Fondazione Giuseppe Dessì di Villacidro. |